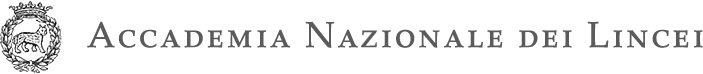La crisi dei Servizi Sanitari Universalistici
Comunicato a seguito del Convegno presso l’Accademia dei Lincei, 21 Febbraio 2025
Vi sono segnali di crisi dei servizi sanitari pubblici in diversi paesi europei. Tali segnali sono particolarmente evidenti in Italia dove il valore del Fondo Sanitario Nazionale, basato sulla fiscalità generale, è significativamente inferiore alla percentuale di PIL investita nella maggior parte dei sistemi sanitari europei che si fondano sui principi di solidarietà e giustizia distributiva. Ad aggravare la situazione vi è il fatto che l’Italia ha la più alta prevalenza di anziani in Europa (il 24% della popolazione ha più di 65 anni), con conseguente incremento dei costi, legati alle necessità sanitarie degli anziani. La situazione di sofferenza del servizio sanitario pubblico si associa a una incidenza della spesa privata pari al 25% del totale. Essa ammonta a 41 miliardi di euro all'anno per l'assistenza sanitaria (cui aggiungere 25 miliardi all'anno per l'assistenza a lungo termine degli anziani): questa somma va paragonata ai 136 miliardi dell’assistenza sanitaria pubblica. Un tale rapporto tra spesa pubblica e spesa privata può rappresentare una minaccia ai principi dell'universalismo, di uguaglianza ed equità che sono i pilastri fondanti del SSN. Ad aggravare la situazione è una spesa sanitaria privata fortemente disomogenea tra le regioni italiane (ad esempio, 800 euro a persona nelle regioni settentrionali come la Lombardia e l'Emilia-Romagna contro 300 euro a persona nelle regioni meridionali come la Calabria). La distanza tra risorse disponibili nel SSN e i bisogni crescenti dovuti all’aumento dell’incidenza di persone anziane e di pazienti cronici determina l’estensione delle liste d’attesa e un certo grado di elusione della risposta ai problemi sanitari specialmente dei meno abbienti. È crescente il numero di cittadini che rinunciano alle cure per le attese troppo lunghe e per l’incapacità di far fronte ai propri problemi sul mercato privato in ragione di limitate disponibilità economiche. I risultati dell’inchiesta OCSE sulle performance dei sistemi sanitari dal punto di vista dei pazienti (Patient Reported Indicator Survey, PaRIS) sottolineano una qualità dell’assistenza sanitaria percepita dai pazienti italiani sotto la media, anche in confronto con paesi con spesa pro-capite simile a quella italiana. Ad esempio, i pazienti con malattie croniche lamentano carenze nel rapporto con il medico di medicina generale, sia rispetto alla continuità nel tempo di tale rapporto, sia per la durata generalmente molto breve delle consultazioni dei medici di medicina generale. L’aumento delle liste di attesa non è unico per l’Italia ma comune a diversi paesi Europei post COVID-19. In Inghilterra, più di tre milioni di pazienti aspettano tra quattro e dodici mesi per un ricovero ospedaliero. I pazienti in lista di attesa hanno un tempo mediano di dodici settimane.
L'inappropriatezza delle prestazioni sanitarie contribuisce in modo significativo a generare lunghe liste d'attesa, con una significativa e ingiustificata variabilità nei consumi sanitari da parte di abitanti con patologie simili; questo ha un impatto rilevante sui bilanci pubblici, con una quota stimata, nei paesi ad alto reddito, tra il 20 e il 40% delle prestazioni erogate che hanno basso o nessun valore per la salute. Le cause dell'inappropriatezza sono diversificate e includono pregiudizi cognitivi, assenza di chiari percorsi diagnostico-terapeutici soprattutto in caso di multi-morbidità, fattori socioculturali, aspettative, pressioni del mercato e medicina difensiva. È necessario un approccio sistemico che affronti il governo della domanda, favorendo la consapevolezza e il coinvolgimento dei cittadini, lo sviluppo di una cultura scientifica e sanitaria, il controllo delle dinamiche di mercato, il miglioramento della relazione tra servizio sanitario e cittadini (oltre che tra i professionisti dei diversi ambiti), la limitazione degli effetti della medicina difensiva, e la sistematizzazione dei programmi per le Linee Guida e l'”Health Technology Assessment”.
Si dice spesso che in Italia c’è carenza di medici, ma questa affermazione non corrisponde al vero. La densità medica italiana (4 medici per 1000 abitanti) è superiore a quella del Regno Unito (3 medici per 1000 abitanti) o della Francia (3,3 medici per 1000 abitanti). Anche il numero di neolaureati nel nostro Paese è superiore a quello della media Europea; incrementarne la quota senza attenta programmazione rischia di creare fra alcuni anni una popolazione di medici con significative problematiche occupazionali. Ciononostante, esistono ampie lacune nella formazione specialistica, in particolare in discipline come medicina d’urgenza ed emergenza, medicina di comunità e cure primarie, microbiologia e virologia, anatomia patologica, radioterapia, chirurgia generale e altre. Il problema non è la carenza di medici in generale, ma la carenza di specialisti in alcune discipline, che può essere attribuita alla scarsa attrattività di queste specializzazioni. Al contrario, le discipline che offrono opportunità nel settore privato, come la dermatologia, l'oftalmologia, la pediatria e la cardiologia, non mostrano segni di crisi; in sostanza, vi sono distorsioni nell’allocazione delle risorse di personale dovute agli incentivi del mercato sanitario privato. Si assiste in effetti a una emorragia di operatori sanitari dal settore pubblico verso quello privato. Questa è riconducibile ad una scarsa attrattività delle professioni sanitarie nel settore pubblico, non solo per le retribuzioni relativamente basse, ma anche per aspetti gestionali, organizzativi e amministrativi. La carenza è particolarmente importante per il settore infermieristico e questo è un problema cronico del nostro Paese, seppur marcatamente acuitosi nel corso degli ultimi anni (anche per effetto della curva pensionistica e delle dimissioni precoci), e per il quale vanno attivate strategie di ampio respiro sia per incentivare l’attrattività della professione che per mantenere gli infermieri in servizio.
La ricerca sanitaria è parte integrante di un sistema complesso come il SSN. Per rafforzare il ruolo della ricerca nel SSN, dobbiamo agire su più fronti. E’ necessario semplificare la burocrazia, rendendo più rapide le procedure di approvazione degli studi clinici e dei finanziamenti. Aumentare gli investimenti per assicurare risorse costanti e accessibili e quindi sostenibili, così come migliorare l’interoperabilità dei dati, sviluppando infrastrutture digitali sicure ed efficienti. Non possiamo poi trascurare la formazione e la valorizzazione del personale sanitario, affinché sia sempre aggiornato sulle nuove tecnologie e metodologie di ricerca, né ignorare la necessità di ridurre le disuguaglianze territoriali, potenziando la ricerca anche nelle aree con minori risorse. Infine, è cruciale promuovere una cultura dell’innovazione, sensibilizzando tutti gli attori del sistema sull’importanza della ricerca per il miglioramento continuo del sistema salute. Affrontare queste sfide con politiche mirate e investimenti adeguati è la chiave per un SSN moderno, efficiente e basato sulle migliori evidenze scientifiche. Solo attraverso un impegno costante nella ricerca potremo garantire cure migliori, un accesso equo all’innovazione e una maggiore resilienza del nostro sistema sanitario di fronte alle sfide future.
L’avanzamento biotecnologico offre oggi opportunità di cura a patologie, fra le quali anche le malattie rare, che solamente pochi anni fa apparivano senza concreta possibilità di efficace trattamento. Ma i farmaci e i trattamenti più innovativi hanno costi che rischiano concretamente di essere non sostenibili per un SSN come il nostro. Servono, dunque, investimenti in ricerca accademica, magari anche attraverso azioni coordinate a livello europeo, per garantire miglior sostenibilità, e necessitano nuovi modelli per fissare rimborsi che siano basati, oltre che su ragionevoli margini di profitto, sui reali benefici per i pazienti, sui costi di sviluppo, validazione e produzione.
La prevenzione nel nostro paese è stata finora negletta. Questo è evidenziato anche dai dati del Nuovo Sistema di Garanzia del Ministero della Salute che misura il livello di raggiungimento dei LEA nelle regioni ed a livello di sistema: anche se l’indicatore globale (nazionale) raggiunge il valore della sufficienza nel 2023 (ma in riduzione rispetto al 2022), esistono ancora distanze significative tra regione e regione con valori che su una scala di 100 variano tra 40 a 98. Si spende sempre di meno in interventi di prevenzione e gran parte degli indicatori sui fattori di rischio individuali (es. abitudine al fumo, alcol, attività fisica, obesità etc) ed ambientali (es. inquinamento atmosferico) mostrano una stabilità negli ultimi anni o addirittura un peggioramento. Vi è urgenza di interventi legislativi che aumentino la tassazione su alcuni prodotti (tabacco, zucchero) e risanino l’ambiente, e un grande sforzo di comunicazione per l’educazione alla salute che può partire dalla scuola dell’obbligo. La prevenzione è una rivoluzione culturale che ha il grande pregio di opporsi al mercato della medicina che, come tutti i mercati, non può che voler crescere. Aumentare la cultura della prevenzione richiede uno sforzo coordinato, che potrebbe esser facilitato dalla creazione di una Scuola Superiore di Sanità per formare i dirigenti del SSN.
Conclusioni
Le scienze mediche sono al servizio della società e la mutualizzazione del contributo fiscale in funzione del reddito è stata un pilastro del nostro convivere, per avere una sanità pubblica di grande qualità in buona parte dell’Italia, un’ottima preparazione universitaria e una adeguata, anche se certamente non abbastanza capillare distribuzione nelle diverse aree della nazione. Ora la spesa pubblica non basta più per sopperire alle necessità di personale sanitario e presidi medici o strutture ospedaliere adeguati a coprire le necessità della popolazione.
Si va verso l’indebolimento del SSN, una conquista straordinaria dello stato sociale: la distanza tra risorse in campo e bisogni sta crescendo, l’eterogeneità dei trattamenti tra pazienti omogenei è chiaramente rilevabile, la sanità privata sta conquistando quote di mercato e sorprende come ci stiamo assuefacendo al ricorso al privato per riuscire ad avere visite specialistiche o interventi in tempi compatibili con le esigenze della salute. I servizi sanitari distrettuali sono carenti e la riforma territoriale legata alla missione 6 del PNRR è attuata con lacune, incoerenze e ritardi. La funzione della medicina di base e del rapporto dei medici di medicina generale con il Servizio Sanitario Nazionale è irrisolta. La situazione sta diventando sempre più pervasiva, alimentando la sperequazione tra ricchi e poveri. Queste dinamiche non sono uniche all’Italia. Diversi paesi europei, incluso il SSN inglese, affrontano problemi analoghi. Un dialogo a livello europeo può essere una fonte di ispirazione per identificare soluzioni.
Porre rimedio a questa situazione si può; ci sono ragioni morali per farlo ed è un problema soprattutto culturale: il poter essere curati quando ci si ammala è l’essenza di una società giusta e il fondamento stesso dell’essere liberi. Farsi carico della salute dei cittadini implica un’enorme responsabilità, che non può essere delegata a organizzazioni private, costruite attorno a numeri e profitti. Deve essere un vero e proprio “servizio”, ispirato al diritto di tutti a cure adeguate e al desiderio di alleviare il dolore degli altri, con attenzione ai dettagli e alla qualità dei servizi erogati.