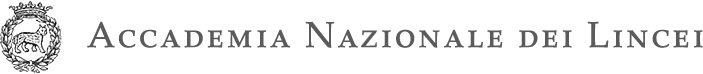Francesco Bruni, professore emerito dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, si è spento il 24 giugno 2025. Allievo di Salvatore Battaglia, ha studiato all’Università Federico II di Napoli, dove è stato assistente, prima presso la cattedra di Filologia romanza e poi presso quella di Letteratura italiana, dal 1965 al 1975. Come professore ordinario di Storia della lingua italiana ha insegnato presso l’Università di Bari dal 1975 al 1978, alla “Federico II” di Napoli nel decennio successivo, presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Verona dal novembre 1988 all’ottobre del 1991, e successivamente all’Università di Venezia.
È stato Accademico dei Lincei e della Crusca, membro delle Accademie Pontaniana, dell’Arcadia, degli Agiati di Rovereto, socio dell’Istituto veneto di Scienze, lettere e arti e della Società nazionale di Scienze, lettere e arti di Napoli. È stato il secondo presidente, dopo Ignazio Baldelli, dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) e ha presieduto il Comitato tecnico per l’istituzione della Facoltà di Lingua e Cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia. È stato inoltre visiting professor nelle università di Girona, Ayn Shams del Cairo, Chicago, Toronto, Los Angeles.
Condirettore di importanti riviste di italianistica, come il «Giornale storico della letteratura italiana» e «Lingua e stile», ha coordinato serie editoriali di particolare rilevanza per gli studi storico- linguistici, quali L'italiano nelle regioni. Lingua nazionale e identità regionali (Utet/Garzanti), Storia della lingua italiana (Il Mulino) e una collana su temi di storia dell’italiano all’interno della serie “Itinerari” del Mulino.
I suoi vasti interessi scientifici coprono quasi l’intero arco cronologico della nostra storia linguistica e culturale, con particolare attenzione ai testi del Trecento, alle opere di Giovanni Boccaccio (importante il libro Boccaccio. L’invenzione della letteratura mezzana, Il Mulino 1990), agli autori e alle discussioni sulla lingua dell’Umanesimo e del Rinascimento, agli scritti e alla riflessione linguistica di Alessandro Manzoni, alla prosa verista del secondo Ottocento, ai versi di Leopardi, Saba, Ungaretti, Montale. Sensibilità particolare hanno mostrato le sue ricerche dedicate al contributo francescano e domenicano alla diffusione del volgare, in cui lo studioso si sofferma con grande originalità sui testi e sulla predicazione del Movimento dell’Osservanza. Nella fase finale dei suoi studi, Bruni ha dato maggior rilievo alla dimensione storica che, pur avendo sempre caratterizzato la sua ricerca, ha trovato centralità nelle ultime monografie, pubblicate tutte con Il Mulino: La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini (2003), Italia. Vita e avventure di un’idea (2011), Idee d’Italia. Da Napoleone al Quarantotto (2021).
In una stagione di particolare vivacità per gli studi e le discussioni sulla Storia della lingua italiana, Francesco Bruni ha dato interpretazioni originali, che hanno segnato molte delle ricerche successive. Ricordiamo, soprattutto, lo scavo tra le carte, gli archivi, i testi fino a quel momento trascurati, che con una nutrita squadra di studiosi ha voluto condurre tra le regioni d’Italia, dimostrando come l’italiano fosse riuscito a trovare una sua via di penetrazione anche prima dell’Unità. A lui si deve anche un primo fondamentale studio sui testi scritti in modo incerto e distante dalla comunicazione alta da lui definiti semicolti, una definizione su cui da quel momento in poi ancora ci confrontiamo. Sempre a Francesco Bruni sono da ricondurre sia la denominazione data all’italiano di lingua senza impero, per indicarne la diffusione solo per virtù di un’importante storia culturale, sia i percorsi della nostra lingua fuori dai confini della penisola, l’una e gli altri affidati ai saggi Una lingua senza impero: l’italiano, Ca’ Foscari 2001, L’italiano fuori d’Italia, Cesati 2013 e a quelli raccolti in Tra popolo e patrizi. L’italiano nel presente e nella storia, Cesati 2017.